

Miguel Benasayag Filosofo e psicoanalista, fondatore del collectif Malgré tout
Ugo Morelli Professore di Scienze cognitive applicate alla vivibilità, al paesaggio e all’ambiente presso l’Università degli Studi di Napoli, Federico II
Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta.
È “un incontro di amicizia e complicità”, come loro stessi lo definiscono, quello tra Miguel Benasayag e Ugo Morelli, il primo a dibattere insieme dei temi affini di cui da sempre si occupano. Un’opportunità unica, che Synasis offre ai suoi iscritti per fare il punto sulla crisi dell’individuo nell’epoca difficile che stiamo vivendo, cercando di proporre una diagnosi del malessere diffuso e individuare prospettive di cura.
Benasayag esordisce indicando l’angoscia quale asse che struttura ormai le nostre vite, attanagliate dalla visione di un futuro non più “promessa”, bensì “minaccia”. Il caos permea non solo l’individuo, ma l’intera società, da almeno un decennio, impedendoci di programmare. Una situazione storicamente inaudita – non ha remore a definirla da filosofo – caratterizzata da un orizzonte fosco e da una sempre più diffusa violenza. Usciti da quella modernità che si apriva ottimisticamente sul domani, dobbiamo invece fare i conti coi guasti di una concezione eurocentrica e coloniale, predatrice del pianeta e indifferente alle sue creature. D’altra parte, riflette Benasayag con visione da psicoanalista, non possiamo neppure ripiegarci su un pessimismo intellettuale narcisistico, ma dobbiamo chiederci invece come reagire, come curare. Insomma: “che fare?”.
Morelli, che trova una forte risonanza del lavoro di Benasayag con il proprio, approfondisce il tema della crisi del legame sociale, dell’indifferenza diffusa che ha ormai provocato la sospensione della risonanza affettiva tra noi. Lo psicologo ammonisce come sia ormai necessario riconoscere di essere solo una parte dell’universo, deponendo la presunzione delirante che tutto sia stato creato per noi umani. Un atteggiamento di assoluto egoismo, che si inserisce nel permeante contesto neoliberista. Dovrebbe invece scomparire la convinzione di essere l’ultima generazione, contemplando finalmente il passaggio generazionale. Morelli suggerisce di cercare nel presente le condizioni per l’emancipazione, un “hic et nunc” che apra al futuro, basato sulla “relazione”. Lavoro e ambiente gli ambiti dove iniziare ad applicarla.
Nella crisi irreversibile dell’antropocene i due studiosi concordano sulla formulazione propositiva di una “nuova educazione”, condizione ormai necessaria di questo presente.
Dialogo tra Miguel Benasayag e Ugo Morelli
Medico chirurgo (psichiatra, psicoterapeuta, neurofisiopatologo, neurologo, neuropsichiatra infantile, medico di comunità, medico di medicina generale, pediatra, pediatra di libera scelta)
Psicologo, Psicoterapeuta
Assistente sanitario
Educatore professionale
Fisioterapista
Infermiere, Infermiere pediatrico
Logopedista
Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Terapista occupazionale

Salvatore Freni Libero professionista, fondatore e presidente dell’Associazione “Centro Studi Inconscio & Civiltà” e docente nelle scuole di psicoterapia COIRAG di Milano e SPP di Torino.
Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta.
Quale contributo può dare la psicoanalisi laddove si richieda un cambiamento di portata antropologica? È la domanda che si pone Salvatore Freni, psichiatra e psicoanalista, nell’analizzare le forme mentali pervasive della società contemporanea: le dipendenze giovanili come alcool, droghe, psicofarmaci, new media, e le nuove patologie, quali il Sé normopatico e il Sé trasmissivo.
L’epistemologia della complessità ci insegna quanto sia difficile cambiare un sistema essendone parte. Anche psicologi, psichiatri psicoanalisti ne fanno parte, soggetti al paradigma economicotecnologico e alla riduzione dell’organico al meccanico. Noi abbiamo divinizzato Freud ma abbiamo disatteso la portata rivoluzionaria delle sue scoperte. Dopo 120 anni di psicoanalisi, di filosofia, di psicologia fenomenologica, disponiamo di una tale quantità e qualità di conoscenze teoriche e di esperienze pratiche da poter sostenere che la dottrina psicoanalitica abbia molto da dire su come stia andando il pianeta.
Se finora è stato necessario proteggere la separatezza all’interno del setting, ora bisogna che gli psicoanalisti escano dagli studi per imparare.
Possono gli psicoanalisti realizzare questa rivoluzione? Si tratta di andare verso la costituzione di un organismo internazionale, una “antropopsicoanalisi politica” come voce critica, abituata com’è a saper mantenere una posizione equidistante, allenata alla “capacità negativa”, per
promuovere una missione di trasparenza, verità, consapevolezza nei governi della cosa pubblica, affinché l’agire antropico abbia come fine primario il bene comune degli umani e del pianeta che ci ospita.
L’auspicio, citando Albert Camus e Il futuro della civiltà europea, è per il ruolo dell’Europa, luogo della diversità delle opinioni, delle contrapposizioni, dei valori contrastanti, affinché possa dare il contributo più importante a quel pluralismo che è sempre stato il fondamento della
nozione di libertà europea. Oggi è in pericolo e bisogna cercare di preservarlo. Di fronte a fermenti nazionalisti, sovranismi, populismi, l’Europa rischia di avviarsi verso una decadenza insanabile. In tal senso ha un ruolo il capitalismo selvaggio che si appresta a depredare altri mondi con l’aiuto di tecnologie inquietanti. Ed è già pronta la perturbante I.A. (intelligenza artificiale) che alcuni esperti temono possa giungere ad espropriarci del nostro Io.
“Formae mentis pervasive nella società contemporanea” – Salvarore Freni
Medico chirurgo (psichiatra, psicoterapeuta, neurologo, neuropsichiatra infantile, medico di comunità)
Psicologo, Psicoterapeuta
Educatore professionale
Infermiere
Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Terapista occupazionale

Alessandra Aloisi Lettrice in francese all’Oriel College e al Wadham College, Università di Oxford
Marco Belpoliti Saggista, scrittore e professore universitario, è direttore della rivista e casa editrice nel web www.doppiozero.com
Enrico Campo Assegnista di ricerca post doc di tipo A, Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti”, Università di Milano
Andrea Nardi Docente e tutor presso l’Università Telematica degli Studi IUL
Alessandra Sarchi Scrittrice, storica dell’arte e traduttrice
Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta.
Critica o elogio della distrazione? Secondo nuove prospettive cui le scienze umane e le discipline scientifiche stanno guardando, la distrazione avrebbe in sé anche elementi di immaginazione e creatività, proficui per la realizzazione di un’opera artistica o di un paper scientifico. Nell’era delle nuove tecnologie che impongono device di lettura, scrittura, calcolo digitali, ci si domanda anche quale possa essere lo scarto provocato della distrazione nel ritorno al tradizionale supporto cartaceo.
Marco Belpoliti in Pensare, distrarsi, scrivere affronta il tema da scrittore e ancor più da lettore. Rilevando la bidimensionalità degli schermi digitali rispetto alla tridimensionalità del libro cartaceo inclusiva del nostro corpo, ricorda la connessione tra capacità manuali e attività intellettuali. Un elogio della scrittura a mano, attività complessa che coinvolge 29 ossa dall’omero al pollice. Ma dacché viviamo nel mondo odierno, non possiamo far altro che cercare di riequilibrare il nostro rapporto con le tecnologie digitali.
In Leggere e comprendere nell’epoca degli schermi digitali Andrea Nardi analizza in prospettiva psicologica le implicazioni cognitive e le fasi di apprendimento nel passaggio dalla lettura su carta a quella su schermo digitale. Un graduale trasferimento che sta avvenendo a livello mondiale regolando l’accesso alla conoscenza dell’intera umanità. Nel processo gli studiosi hanno già notato fattori di impoverimento cognitivo, tanto più negli utenti svantaggiati. Ma si confida sulla capacità di adattamento dell’essere umano.
Argomenta un elogio della lettura Alessandra Sarchi in Cosa vediamo quando leggiamo? La scrittrice ne ricorda la competenza solo nostra, di specie, della lettura, che si apprende da bambini e ci accompagna per molti anni. Ma la vera domanda è: cosa riusciamo a immaginare quando leggiamo? E chiude lanciando una sfida ai nostri uditori, professionisti della sanità: la lettura di una cartella clinica, oltre ai dati di anamnesi e diagnostici, si apre a ricomporre l’intera dimensione della persona paziente?
Con visione da linguista Alessandra Aloisi in Storia della concentrazione e della distrazione mette in discussione l’idea corrente della distrazione incompatibile con la concentrazione nella pratica della lettura. Rilanciando invece la prospettiva della distrazione quale capacità in se stessa, in grado di produrre un nuovo modo di pensare e concepire. Oltre al piacere della rêverie nella lettura di un libro, la distrazione dimostra tutta la sua potenza nell’esercizio dell’arte. Fenomeni complessi e plurali, che è giunto il momento di ripensare.
Enrico Campo applica la sua prospettiva di sociologo in Crisi della lettura e crisi dell’attenzione? A proposito degli effetti del digitale. L’analisi della crisi della lettura e in generale dell’attenzione nelle società occidentali è messa inevitabilmente in relazione con la diffusione delle tecnologie digitali. L’analisi storica permette di valutare le conseguenze della crisi dell’attenzione, ma anche di immaginare possibilità alternative a un fenomeno ormai inevitabile.
“Pensare, distrarsi, scrivere” – Marco Belpoliti
“Leggere e comprender nell’epoca degli schermi digitali” – Andrea Nardi
“Cosa vediamo quando leggiamo?” – Alessandra Sarchi
“Storia della concentrazione e della distrazione” – Alessandra Aloisi
“Crisi della lettura e crisi dell’attenzione? A proposito degli effetti del digitale” – Enrico Campo
Medico chirurgo (psichiatra, psicoterapeuta, neurologo, neuropsichiatra infantile, medico di comunità, medico di medicina generale, pediatra, pediatra di libera scelta)
Psicologo, Psicoterapeuta
Assistente sanitario
Logopedista
Fisioterapista
Educatore professionale
Infermiere
Infermiere pediatrico
Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Terapista occupazionale

Raffaella Lops Agente letteraria.
Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta.
Per ottenere i crediti ECM è obbligatorio partecipare a tutti gli incontri.
Il corso è strutturato come un gruppo di lettura e prevede quattro incontri durante i quali, sotto la guida di Raffaella Lops, saranno approfonditi i seguenti libri: Il posto, dell’autrice francese Annie Ernaux, Premio Nobel per la Letteratura nel 2022; Stranieri a noi stessi, saggio narrativo della pluripremiata giornalista del New Yorker Rachel Aviv; La figlia oscura, romanzo di Elena Ferrante dal quale la regista Maggie Gyllenhaal ha tratto un film nel 2021 con protagoniste Olivia Colman e Dakota Johnson; e infine L’educazione, romanzo di esordio di Tara Westover, divenuto un best seller negli Stati Uniti.
I quattro incontri, distribuiti su altrettanti mesi, saranno dedicati di volta in volta a uno dei testi e permetteranno al gruppo di affrontare i diversi temi proposti, che spaziano dalla perdita di un linguaggio comune con i genitori, alla relazione tra identità e diagnosi psichiatrica, dalle questioni meno esplorate legate all’essere madre, alla forza liberatrice che può generare dall’educazione.
Obiettivo del corso è approfondire il legame tra la lettura e la narrazione di sé: parlare di un libro, parlarne davvero, e farlo con altri, equivale infatti a dire qualcosa di profondo su se stessi, sulle proprie relazioni, sul rapporto con i ricordi e con il presente. La lettura dei testi e le attività proposte durante gli incontri agevoleranno l’emergere di riflessioni personali nei partecipanti e permetteranno di costruire un’esplorazione comune nel corso del dibattito in classe.
> 19 giugno, 18.00-19.30
Come i romanzi parlano di noi: Il posto di Annie Ernaux
> 25 settembre, 18.00-19.30
Come i romanzi parlano di noi: Stranieri a noi stessi di Rachel Aviv
> 15 ottobre, 18.00-19.30
Come i romanzi parlano di noi: La figlia oscura di Elena Ferrante
> 20 novembre, 18.00-19.30
Come i romanzi parlano di noi: L’educazione di Tara Westover
Sono disponibili 25 posti che saranno assegnati ai primi 25 iscritti che si presenteranno all’incontro del 19 giugno e che, come da pre-requisito richiesto, avranno letto il libro oggetto di discussione.
Medico Chirurgo: Medico di comunità, Neurologo, Neuropsichiatra infantile, Psichiatra, Psicoterapeuta, Medico generale, Pediatra, Pediatra di libera professione
Psicologo, Psicoterapeuta
Educatore Professionale
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva
Terapista Occupazionale
Infermiere; Infermiere pediatrico
Assistente Sanitario
Fisioterapista
Logopedista
Ostetrica

Anil Seth Professore di Neuroscienze cognitive e computazionali presso l’Università del Sussex e codirettore del programma di ricerca “Cervello, mente e coscienza” del Canadian Institute for Advanced Research.
Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta.
Che cosa significa essere sé, ossia avere un’esperienza cosciente del mondo che ci circonda e del nostro mondo interiore? Storicamente, l’umanità ha considerato la natura della coscienza come oggetto di indagine primariamente filosofica. Oggi però la ricerca scientifica sta delineando teorie e spiegazioni biologiche della coscienza e del sé estremamente affascinanti e convincenti.
Nel corso Synapsis, Anil Seth, neuroscienziato e autore di fama, ci aiuta a comprendere come il cervello crei la nostra esperienza cosciente. La sua tesi radicale, espressa nel pluripremiato volume Come il cervello crea la nostra coscienza (edito in italiano da Raffaello Cortina Editore), è che noi non percepiamo il mondo così come oggettivamente è. Piuttosto, siamo macchine predittive: inventiamo di continuo il nostro mondo e correggiamo i nostri errori in un microsecondo. E siamo ora in grado di osservare i meccanismi biologici del cervello che creano la nostra coscienza.
Scrive lo stesso autore nella prefazione del volume: «Questo libro si occupa della neuroscienza della coscienza: il tentativo di comprendere come l’universo interno dell’esperienza soggettiva sia legato a, e possa essere spiegato in termini di, processi biologici e fisici che si sviluppano in cervelli e corpi. Questo progetto mi ha affascinato per tutto il corso della mia carriera e credo che abbia ora raggiunto un punto in cui dei barlumi di risposte stanno cominciando ad emergere. Già questi barlumi cambiano, e cambiano radicalmente, il modo in cui pensiamo le esperienze coscienti del mondo intorno a noi e di noi stessi al suo interno. Il modo in cui concepiamo la coscienza tocca ogni aspetto della nostra vita. Una scienza della coscienza altro non è che una spiegazione di chi siamo e di cosa si prova ad essere me, a essere voi, o del perché vi sia qualcosa che si prova a “essere” in generale. La storia che racconterò è una visione personale, formatasi in molti anni di ricerca, meditazione e conversazioni. […] Ciò che spero di mostrarvi è che, spiegando le proprietà della coscienza nei termini di meccanismi cerebrali e corporei, la metafisica profonda dei perché e dei come relativi alla coscienza diventa, pian piano, meno misteriosa».
Lezione di Anil Seth
Medico chirurgo: Psichiatra, Psicoterapeuta, Neurologo, Neuropsichiatra infantile, Medico di comunità
Psicologo, Psicoterapeuta
Assistente sanitario
Educatore professionale
Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Terapista occupazionale
Infermiere
Logopedista
La lezione in lingua originale (non valida ai fini ECM) è disponibile sul canale YouTube di Fondazione Hapax, cliccando qui
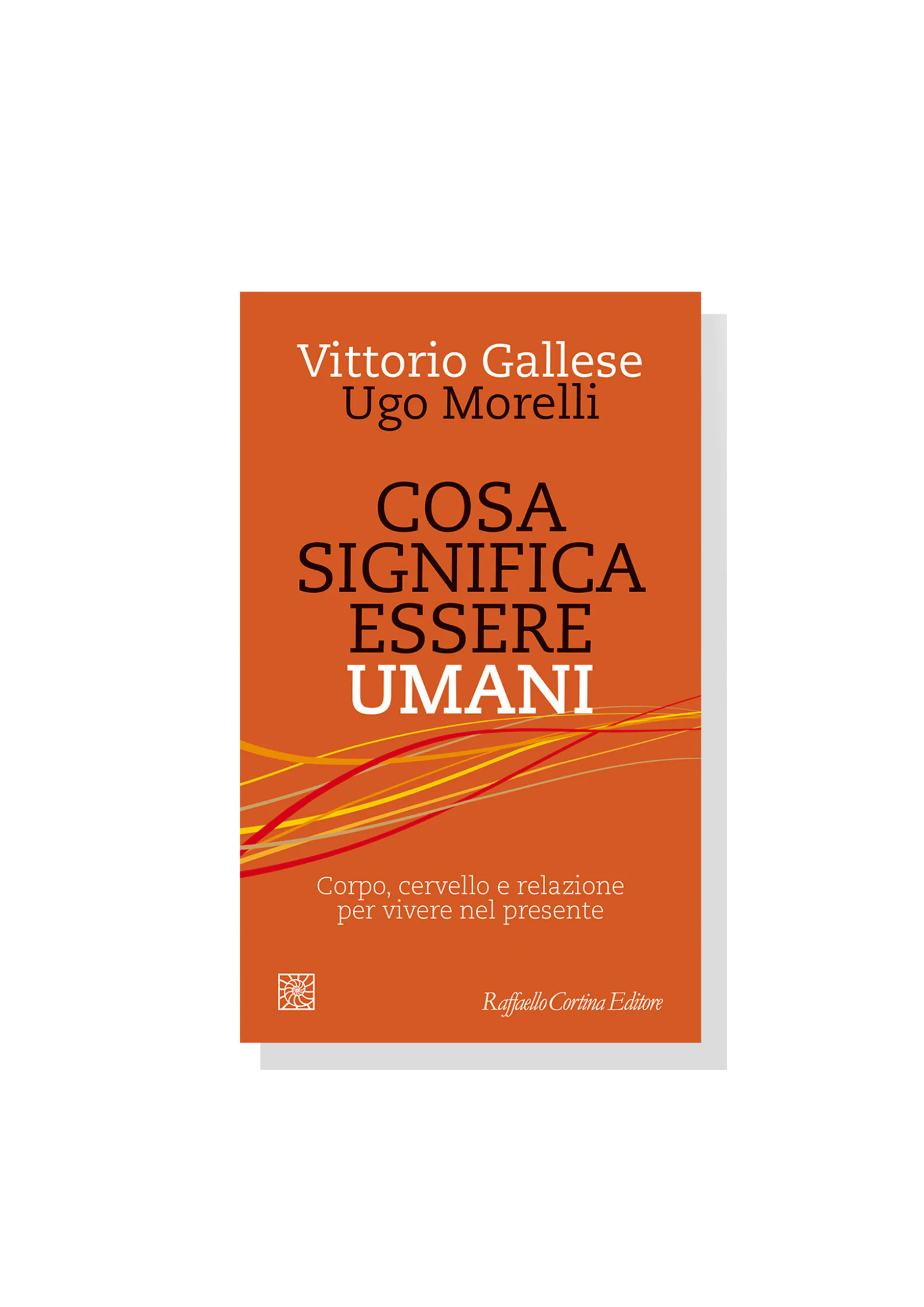
Vittorio Gallese Professore Ordinario di Psicobiologia presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Unità di Neuroscienze – dell’Università di Parma.
Ugo Morelli Professore di Scienze cognitive applicate alla vivibilità, al paesaggio e all’ambiente presso l’Università degli Studi di Napoli, Federico II.
Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta.
Una rivoluzione di portata copernicana è sotto i nostri occhi. Coinvolge ognuna e ognuno di noi e ridefi nisce alla radice cosa siamo come esseri umani. Dal primato del soggetto scopriamo la centralità della relazione; da individui ci riconosciamo condividui; da tanti “io” che pensavamo
di essere ci accorgiamo di derivare dai “noi” di cui siamo parte; oltre la centralità della mente riconosciamo fi nalmente di essere un corpo; scopriamo che l’origine della conoscenza è situata nella nostra capacità di azione e movimento.
Un paradigma corporeo, basato sull’intersoggettività, si fa strada nella comprensione di noi stessi e attende di essere riconosciuto per una collocazione più appropriata della nostra presenza e una lettura più adeguata della nostra esperienza. I sentieri narrati in questo piccolo libro si propongono come un agile vademecum per viandanti planetari quali noi siamo.
Acquistando il corso Cosa significa essere umani, è possibile accedere anche a Corpo, cervello e relazione per vivere nel presente, due lezioni di Vittorio Gallese e Ugo Morelli.
Tre decenni di ricerca empirica hanno modificato profondamente le nostre concezioni riguardo al modo in cui gli esseri umani si sviluppano e apprendono a relazionarsi gli uni gli altri e a comprendersi. L’infant research, la psicologia dello sviluppo, e le neuroscienze cognitive hanno mostrato sempre più e meglio l’imprescindibile ruolo nella cognizione sociale della nostra natura corporea relazionale.
La lezione di Vittorio Gallese affronta il tema della centralità della relazione interumana, declinandola sia da un punto di vista psicologico che da quello dei sottostanti meccanismi neurofisiologici. L’intersoggettività viene affrontata secondo l’ottica del paradigma dell’embodied cognition, con particolare attenzione sia alla dimensione implicita/empatica che a quella linguistica della relazione.
La lezione di Ugo Morelli si concentra, invece, sulla definizione delle caratteristiche che distinguono un essere umano dagli altri animali, approfondendo aspetti come l’avvento evolutivo della competenza e del comportamento simbolici – da quel processo evolutivo in avanti noi esseri umani non coincidiamo più con noi stessi, inventiamo mondi paralleli, e soprattutto non solo sappiamo, ma sappiamo di sapere; la capacità di creare e di inventare che ci permette di comporre e ricomporre in modo almeno in parte originale i repertori disponibili del mondo; la creatività e l’esperienza estetica, sodali in quanto riguardano la disposizione a trascendersi della nostra specie. Si giunge così al vertice della bellezza intesa come la risonanza incarnata particolarmente riuscita in modo da estendere la nostra sensibilità e la comprensione di noi stessi, degli altri e del mondo per vie che senza quell’esperienza di bellezza non si verificherebbero.
CORSO 1
> Lettura e studio di Cosa significa essere umani di Vittorio Gallese e Ugo Morelli, Raffaello Cortina Editore
14 crediti ECM
CORSO 2
> “Corpo, cervello e relazione per vivere nel presente”: due lezioni a cura di Vittorio Gallese e Ugo Morelli
2 crediti ECM
Medico chirurgo (psichiatra, psicoterapeuta, neurologo, neuropsichiatra infantile, neurofisiopatologia, medico di comunità, medico di medicina generale, pediatra, pediatra di libera scelta);
Psicologo (psicologo, psicoterapeuta);
Assistente sanitario;
Logopedista;
Educatore professionale;
Infermiere, Infermiere pediatrico;
Fisioterapista;
Ostetrica;
Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
Terapista occupazionale.
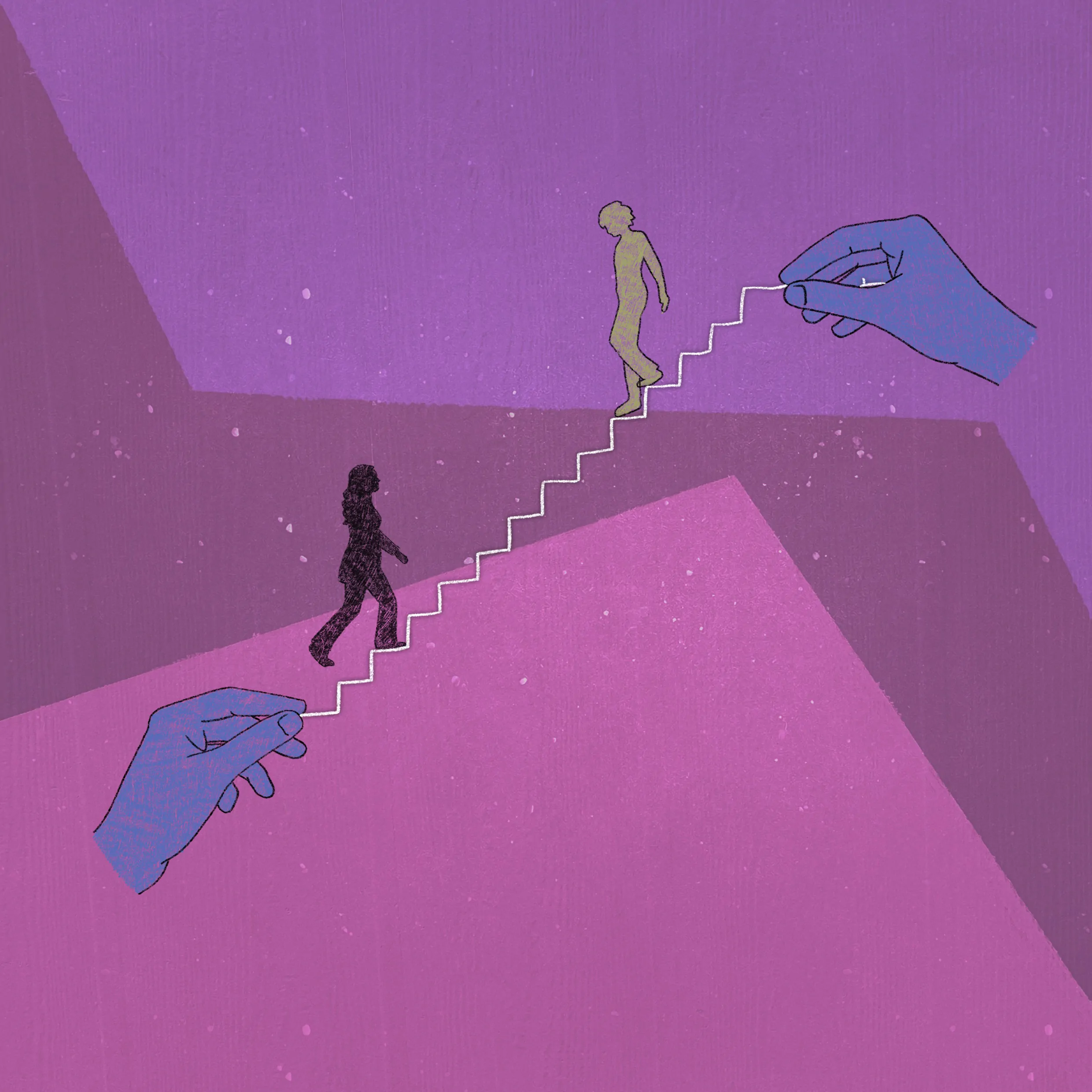
Daniel Kahneman Professore emerito di Psicologia presso la Princeton University.
Andrea Angelozzi Attualmente in quiescienza, è stato direttore del DSM – Aulss 3 Serenissima della Regione Veneto.
Paolo Migone Psichiatra psicoterapeuta, condirettore della rivista Psicoterapia e Scienze Umane.
Vincenzo Villari Direttore Dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale, Direttore S.C. Psichiatria SPDC, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino.
Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta.
La recente scomparsa di Daniel Kahneman è l’occasione per riproporre una lezione tenuta per Synapsis dallo psicologo vincitore del premio Nobel per l’economia «per avere integrato risultati della ricerca psicologica nella scienza economica, specialmente in merito al giudizio umano e alla teoria delle decisioni in condizioni d’incertezza».
Professore all’Università di Princeton, Kahneman è uno dei fondatori della finanza comportamentale. Le sue ricerche hanno permesso di applicare la ricerca scientifica all’ambito della psicologia cognitiva per la comprensione delle decisioni economiche. Dimostrando tramite esperimenti come i processi decisionali umani violino sistematicamente alcuni principi di razionalità, laddove le teorie microeconomiche assumono come razionale e finalizzato a una massimizzazione dell’utilità il comportamento degli agenti decisionali.
Due sono i volumi che riassumono il pensiero e le ricerche di Kahneman, spunti di discussione degli interventi che accompagnano la sua lectio.
In Pensieri lenti e veloci (2012) Kahneman ci guida all’’esplorazione della mente umana, caratterizzata da due processi di pensiero ben distinti: uno veloce e intuitivo (sistema 1), e uno più lento ma anche più logico e riflessivo (sistema 2). Se il primo presiede all’attività cognitiva automatica e involontaria, il secondo entra in azione quando dobbiamo svolgere compiti che richiedono concentrazione e autocontrollo. Efficiente e produttiva, questa organizzazione del pensiero ci consente di sviluppare raffinate competenze e abilità e di eseguire con relativa facilità operazioni complesse. Ma può anche essere fonte di errori sistematici (bias), quando l’intuizione si lascia suggestionare dagli stereotipi e la riflessione è troppo pigra per correggerla.
Due medici danno due diagnosi diverse allo stesso paziente sulla base degli stessi esami; due giudici assegnano pene diverse a colpevoli dello stesso reato; lo stesso manager prende una decisione diversa a seconda del momento della giornata. Non dovrebbe accadere, ma accade. In Rumore (2021) Kahneman, insieme a Olivier Sibony e Cass R. Sunstein, analizza questo difetto del funzionamento mentale e dimostra come ovunque si eserciti il giudizio umano – nella sanità pubblica come nelle aule di giustizia, nelle strategie aziendali come nelle decisioni quotidiane di tutti noi – si trovi il “rumore”, a sviare il ragionamento e causare errori. Un fenomeno onnipresente, finora largamente ignorato: conoscerlo significa riconoscere e controllare l’influenza che il rumore esercita su tutte le decisioni, previsioni e valutazioni.
Gli interventi di Paolo Migone, Andrea Angelozzi, Vincenzo Villari si propongono di focalizzare su medicina e psichiatria il difetto degli errori nella previsione e nella diagnosi.
Introduzione di Paolo Migone
Intervento di Andrea Angelozzi
Lezione di Daniel Kahneman
Dialogo tra Daniel Kahneman, Paolo Migone, Andrea Angelozzi, Vincenzo Villari
Medico Chirurgo: Medico di comunità, Neurologo, Neuropsichiatra infantile, Psichiatra, Psicoterapeuta, Medico generale, Medico legale
Psicologo, Psicoterapeuta
Educatore Professionale
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva
Terapista Occupazionale
Assistente Sanitario
Fisioterapista
Logopedista
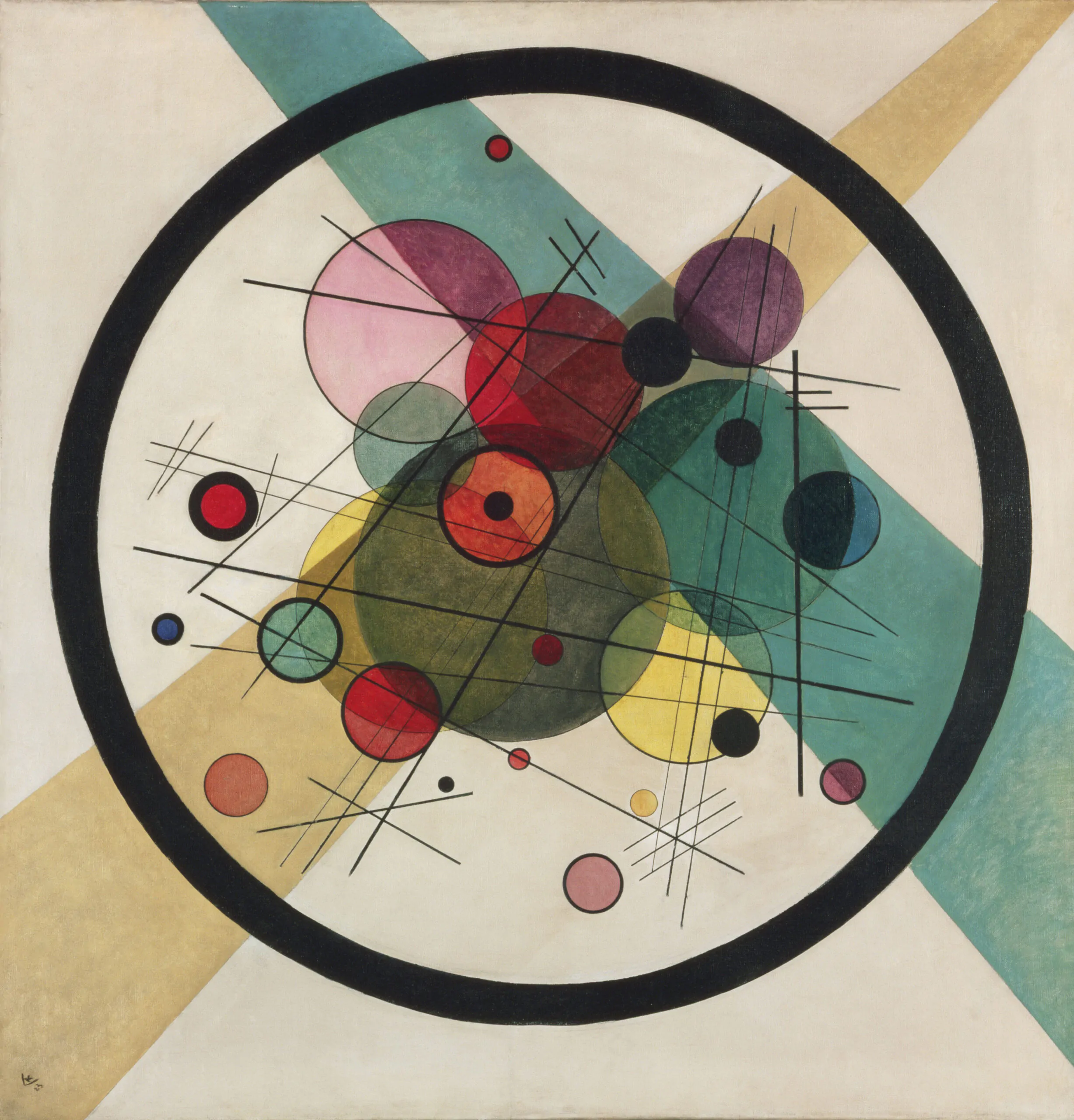
Morris N. Eagle Professore emerito al Derner Institute of Advanced Psychological Studies, Adelphi University di New York e Distinguished Educator in Residence, California Lutheran University.
Nancy McWilliams Psicologa clinica e psicoanalista, docente della Rutgers University (New Jersey, USA), autrice di testi psicoanalitici fondamentali e curatrice della seconda edizione del PDM (Manuale Diagnostico Psicodinamico). È stata presidente della Divisione di Psicoanalisi dell’American Psychological Association (APA).
Paolo Migone Psichiatra psicoterapeuta, condirettore della rivista Psicoterapia e Scienze Umane.
Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta.
Nel webinar presentato da Synapsis, Morris N. Eagle e Nancy Williams si confrontano sulle basi di una Psicologia dell’Io riveduta e ampliata. Lo spunto è il volume dello stesso Eagle Verso una teoria psicoanalitica unificata fondata su una Psicologia dell’Io riveduta e ampliata, di recente pubblicato anche in Italia da Raffello Cortina Editore a cura di Paolo Migone.
Una Psicologia dell’Io riveduta e ampliata rappresenta la base più solida di una teoria unificata della mente e anche di una sua integrazione con i progressi delle altre discipline. Tra le aree in cui la Psicologia dell’Io richiede una revisione vi sono il riconoscimento del ruolo delle relazioni oggettuali per lo sviluppo delle funzioni dell’Io, la relativa autonomia delle relazioni oggettuali dalle pulsioni, una adeguata spiegazione della comprensione interpersonale e una teoria coerente degli affetti con il riconoscimento del loro ruolo motivazionale. Nel volume come nella conversazione vengono inoltre discusse le implicazioni di una Psicologia dell’Io riveduta e ampliata per la concezione della psicopatologia e del trattamento.
Scopo del volume così come del confronto tra i due psicoanalisti americani è integrare gli approcci di differenti scuole e i risultati più rilevanti delle ricerche empiriche in una teoria generale della mente fondata su basi psicoanalitiche.
Una delle tesi principali del libro di Eagle è l’idoneità di una Psicologia dell’Io a porsi come il fondamento più solido non solo per la formulazione di una teoria psicoanalitica unificata, ma anche per l’integrazione dei dati di ricerca più rilevanti di altre discipline.
In modo rigoroso ma accessibile, si illustrano i princìpi di base della Psicologia dell’Io e le revisioni e i correttivi che sarebbe necessario apportarvi. Sono prese anche in esame le ricerche e le teorie sulla comprensione interpersonale, la capacità di inibizione, la difesa, il differimento della gratificazione, le motivazioni e gli scopi autonomi dell’Io, la regolazione degli affetti, la natura della psicopatologia, nonché le implicazioni per l’approccio al trattamento clinico.
Introduzione di Paolo Migone
Dialogo tra Morris Eagle e Nancy McWilliams
Medico chirurgo: Psichiatra, Psicoterapeuta, Neurologo, Neuropsichiatra infantile, Medico di comunità
Psicologo, Psicoterapeuta
Assistente sanitario
Educatore professionale
Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Terapista occupazionale
Infermiere
Logopedista
La lezione in lingua originale (non valida ai fini ECM) è disponibile sul canale YouTube di Fondazione Hapax, cliccando qui.

Daniel C. Dennett Professore di Filosofia e Direttore del Centro per gli Studi Cognitivi alla Tufts University.
Benedetta Giovanola Professore Ordinario di Etica presso l’Università di Macerata e Titolare della Cattedra Jean Monnet – Ethics for inclusive digital Europe.
Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta.
La coscienza è davvero ciò che ci distingue dagli altri esseri viventi? È riducibile a processi biochimici? Se sì, che ruolo hanno in tali processi il dolore e l’amore, i sogni e la gioia? Sono alcune delle eterne domande su cui si consumano filosofi e scienziati a partire da Cartesio.
Nel suo volume Coscienza, ormai considerato un classico e ripubblicato di recente in Italia da Raffaello Cortina Editore, Daniel C. Dennett sostiene che le teorie sulla coscienza siano tutte errate, benché la loro semplicità intuitiva ci spinga a crederle vere. Teorie ribadite nel webinar proposto da Synapsis, in cui il filosofo della mente americano, oggi ottuagenario, dialoga con Benedetta Giovanola, docente di Filosofa morale presso l’Università di Macerata. È vero invece, sostiene Dennett, che non vi sia traccia nel nostro cervello di un “autore centrale”, produttore di un unico e definitivo flusso di coscienza. La nostra mente non funziona come una dittatura o una monarchia, bensì come una democrazia molto sofisticata. Secondo le sue parole: «Spiego i vari fenomeni che compongono ciò che chiamiamo coscienza, mostrando come essi siano tutti degli effetti fisici delle attività del cervello. Propongo analogie, esperimenti di pensiero e altri espedienti per rompere vecchi abiti di pensiero e aiutare a organizzare i fatti in un’unica visione, coerente, sorprendentemente diversa dal tradizionale punto di vista sulla coscienza».
Dialogo tra Daniel C. Dennett e Benedetta Giovanola.
Medico Chirurgo: Medico di medicina generale, Medico di comunità, Neurologo, Neuropsichiatra infantile, Pediatra, Pediatra di libera scelta, Psichiatra, Psicoterapeuta
Psicologo, Psicoterapeuta
Educatore professionale
Tecnico della Riabilitazione psichiatrica
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva
Terapista occupazionale
Infermiere, Infermiere pediatrico
Assistente sanitario
Logopedista
Fisioterapista
La lezione in lingua originale (non valida ai fini ECM) è disponibile sul canale YouTube di Fondazione Hapax, cliccando qui.
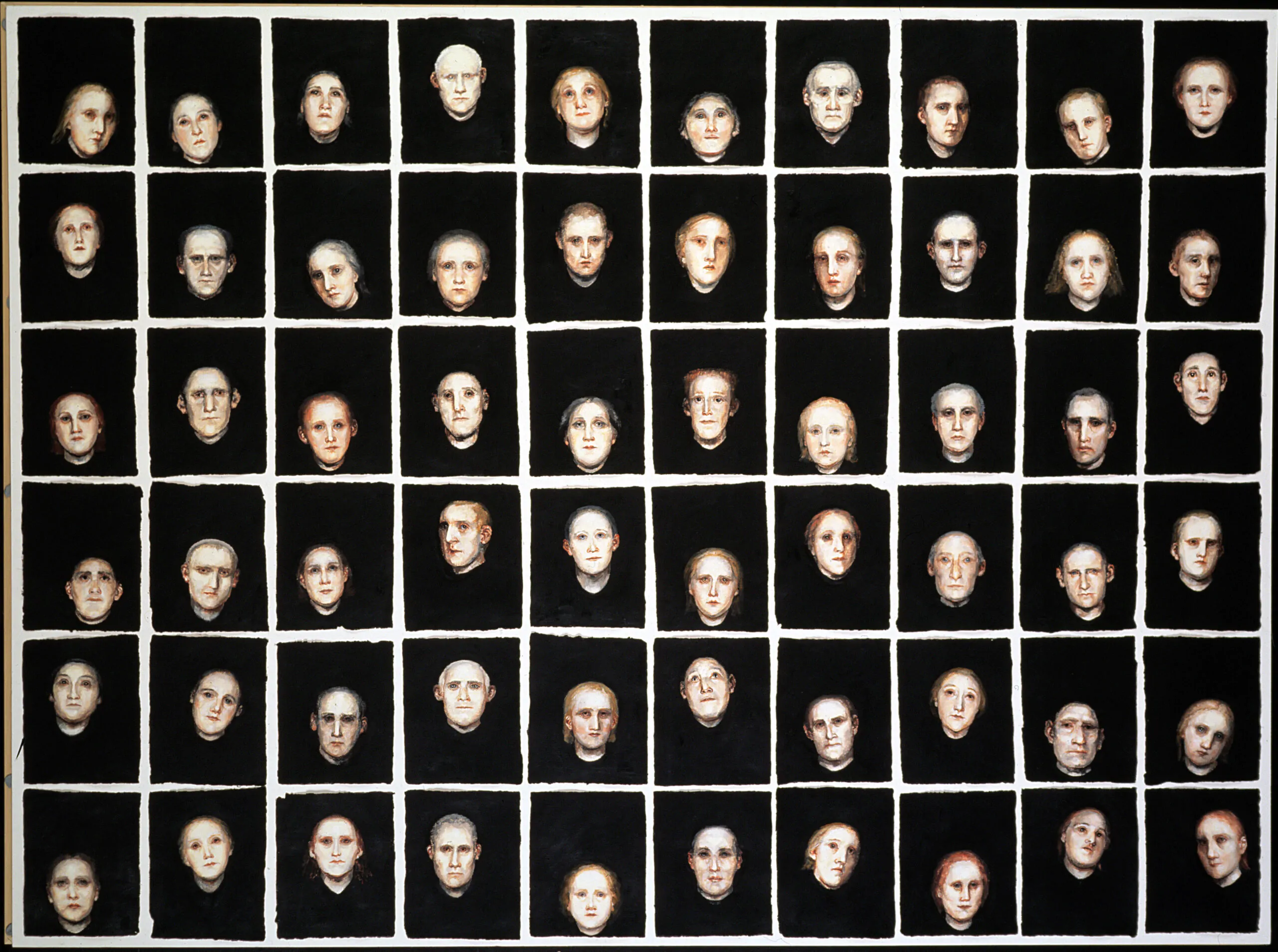
Emilia Margoni Dottoranda in filosofia presso l’Università degli Studi di Firenze.
Laura Pigozzi Psicoanalista, saggista e insegnante di canto.
Enrico Redaelli Docente a contratto di Filosofia e differenza sessuale presso l’Università degli Studi di Verona.
Davide Sisto Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Padova e di Torino.
Antonio Vercellone Ricercatore presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.
Elena Camerone Psichiatra e psicoterapeuta.
Centrale nel dibattito attuale, il tema della differenza viene affrontato in questo ciclo di lezioni da diverse prospettive, tutte riconducibili, a ben vedere, a considerazioni psicologiche, toccando anche l’ambito della cura ampiamente intesa.
Laura Pigozzi induce a riflettere sulla differenza dei legami che si stabiliscono tra sorelle e tra sorelle con la madre. Un argomento cruciale per lo sviluppo della femminilità e la crescita della persona, che accompagna ogni donna, abbia o no una sorella. Un legame originario, ambivalente
tra figura intrusiva o liberatoria rispetto alla relazione con la madre, che anche se mancante o reciso resta sempre in noi. Puntare sul legame sororale (compresa la sorellanza non familiare) aiuta la donna a diventare autonoma e a costruire i propri rapporti, sia in famiglia che nella
società. Il soricidio simbolico non avrebbe alcuna funzione psichica, sarebbe solo una brutale amputazione.
Da giurista Antonio Vercellone affronta il tema del confronto/scontro tra il nostro diritto di famiglia e i nuovi modelli familiari, sempre più diversi, che la società contemporanea genera. La domanda è se l’ordinamento giuridico italiano debba oggi strutturarsi funzionalmente al
pluralismo delle tante evoluzioni della coppia, così come delle innumerevoli modalità di genitorialità. La proposta del relatore è orientata a un diritto non più normalizzante e impositivo, bensì finalmente inclusivo, a tutela delle differenze, capace di abilitare qualsiasi tipo di
formazione di natura familiare e sociale.
Si lega al dibattito suddetto Enrico Redaelli, che tratta la differenza tra i sessi da diversi punti di vista. Partendo dalle distinzioni biologiche, cromosomiche, fenotipiche quali paradigmi storicamente prevalenti si giunge alla problematicità contemporanea nell’individuare il “corretto” criterio di assegnazione del sesso. Le battaglie attuali passano attraverso l’impegno degli attivisti e sentenze della cassazione che fanno giurisprudenza. In Italia la data chiave è 1982, con la legge sulla transizione di genere; in ogni paese si affronti la questione l’evoluzione dei criteri origina sempre un confronto o uno scontro politico.
Le identità differenti che affollano il web, illustrate e problematizzate da Davide Sisto, portano a chiedersi quale possa essere oggi la percezione dell’identità soggettiva. Come già nel mondo asiatico, anche l’Occidente sta per essere invaso da figure virtuali (nel ruolo di influencers) che
raccolgono le infinite identità da noi stessi consegnate alla rete: lo sappiamo me accettiamo volentieri di interagirvi. Il prossimo passo saranno i legami che i vivi manterranno con gli avatar del web ai quali i defunti stessi hanno regalato le proprie identità. Memoria e oblio del fine vita
ai tempi di internet.
In tale panorama rientra il mondo della fisica quantistica. Illustrata da Emilia Margoni, è una branca della fisica con lo scopo principale di studiare i fenomeni microscopici. Scienza all’apparenza distante dalla vita quotidiana, è in realtà strettamente legata alle sue applicazioni.
Basterà pensare alla biologia molecolare, alla genetica, alla biofisica, alle biotecnologie e ad altri ambiti particolarmente affascinanti. La storia di una delle branche meglio verificate e di maggior successo della scienza contemporanea è ripercorsa dai suoi esordi, senza tralasciare le
conseguenze ontologiche che il suo sviluppo ci pone.
“Differenziarsi (madre/figlia)” – Laura Pigozzi
“Differenza e uguaglianza” – Antonio Vercellone
“Differenza di genere” – Enrico Redaelli
“Identità differenti nel web” – Davide Sisto
“Un differente universo: l’universo quantistico” – Emilia Margoni
Medico Chirurgo: Medico di medicina generale, Medico di comunità, Neurologo, Neuropsichiatra infantile, Pediatra, Pediatra di libera scelta, Psichiatra, Psicoterapeuta
Psicologo, Psicoterapeuta
Educatore professionale
Tecnico della Riabilitazione psichiatrica
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva
Terapista occupazionale
Infermiere, Infermiere pediatrico
Assistente sanitario
Logopedista
Fisioterapista